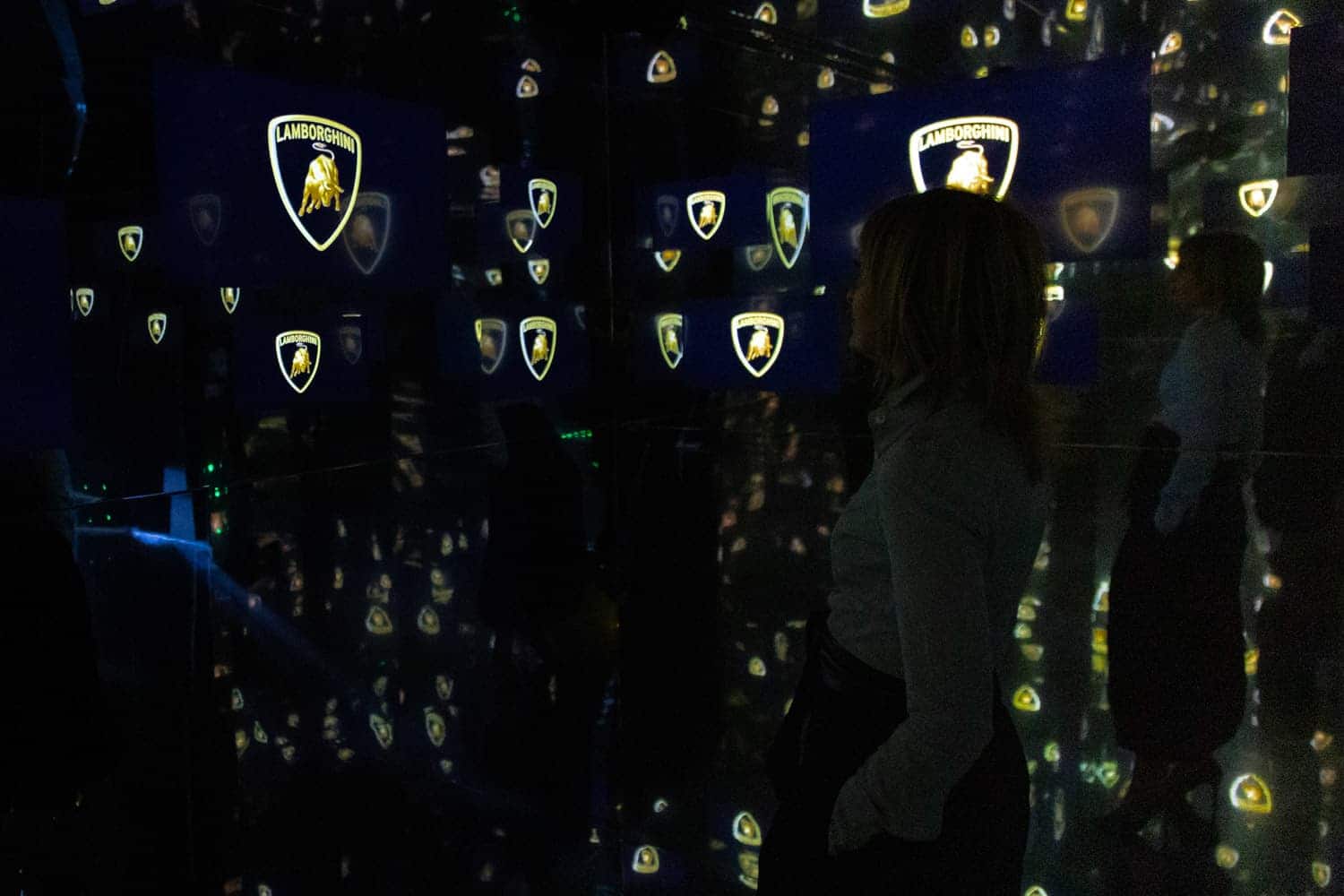Katia Bassi è Chief Marketing and Communication Officer di Lamborghini, nonché prima donna a far parte del board della società. La sua è una storia di successi, ma anche di difficoltà. Scopriamola.
Arrivo a Sant’Agata Bolognese dopo un’interminabile coda sulla A22 e con la sempre più granitica certezza che non esistano più le mezze stagioni. Fa caldo, un caldo intollerabile per essere già ottobre. Alzo lo sguardo verso la distesa di finestre a specchio della sede Lamborghini pensando “ti prego, fa che l’aria condizionata funzioni ancora”.
Ho vissuto per un anno a Mirafiori, a Torino, scorgendo ogni sera dalla finestra l’insegna luminosa Fiat. Nella mia mente, tutto ciò che è azienda automobilistica è associata a strutture imponenti: cancelli altissimi, strutture architettoniche invasive e dal sapore antico e austero. Qui, invece, quasi non ci si accorge di essere nella sede di una delle più prestigiose case automobilistiche mondiali. La prima volta ho mancato clamorosamente l’ingresso dell’azienda mentre percorrevo in auto la statale in mezzo alla campagna. Cominciamo bene, mi sono detta.
L’appuntamento è con Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Lamborghini, nonché prima donna a far parte del board della società. Il web straripa di informazioni che la riguardano attraverso interviste e video dei suoi interventi a numerose convention. Non ho voluto guardarli. Ho raccolto solo le informazioni minime necessarie per poter iniziare un dialogo con lei e non lasciarmi influenzare dal già visto e già letto. Sapevo che avrei incontrato una donna speciale, ma non volevo avere in anticpo la misura di quanto sarebbe stata speciale.
Katia Bassi mi accoglie con un gran sorriso e una gonna strepitosa. Tutto di lei dice sono qui per voi, sono a vostra disposizione quando invece potrebbe dire forza sbrighiamoci ho un’azienda da portare avanti, una call, un meeting e un briefing. E invece no.
Katia Bassi guida una Urus, il super luxury SUV che ha portato Lamborghini verso una nuova fase industriale senza tradire le origini del marchio e il suo stile.
«C’è una splendida luce, meglio fare qualche foto prima che il sole si alzi ulteriormente» dice la fotografa. Saliamo tutti sulla Urus di Katia come se stessimo andando in gita al lago. Anche sulla Urus fa caldo, più caldo che all’esterno: cerco di non fare pensieri strani e inopportuni, tipo mi sa che quest’auto non è coibentata bene.
«Ah ecco, adesso ho capito! C’era la temperatura interna impostata su 26 gradi! Ma chi ha toccato i pulsanti? Proprio non capisco questa cosa». Katia Bassi è una di noi, in fondo.
Si è laureata prima in Scienze Politiche e poi in Giurisprudenza. Voleva a tutti i costi fare il magistrato al Tribunale dei Minori e ha superato l’esame per entrare in magistratura. In Italia, però, un magistrato non può scegliere la propria destinazione, e Katia rischiava di finire in un Tribunale Civile qualsiasi. Così si è occupata di bambini da volontaria.
Prima di conseguire la laurea in Scienze Politiche ha iniziato a lavorare in Swatch, che all’epoca si chiamava SMH Italia, all’interno dell’ufficio marketing di Tissot. Con l’arrivo della seconda laurea le è stata affidata la responsabilità della divisione orologi di lusso Pierre Balmain. «Mi ero prefissata di ottenere la dirigenza prima dei 30 anni e quando la società World Gem di Vicenza mi ha offerto il posto che desideravo, mi sono trasferita. Mi sono occupata delle collezioni di gioielleria potendo intervenire anche nello sviluppo del prodotto, cosa che in Tissot non era possibile fare perché le decisioni venivano prese a livello internazionale».
L’esperienza in World Gem l’ha poi portata in Damiani, dove ha seguito la startup del brand Bliss, e successivamente è entrata nel mondo automotive grazie all’offerta arrivata da Ferrari. «Ho avuto la possibilità di spaziare in vari settori perché ho sempre incontrato persone lungimiranti che non hanno guardato il settore di provenienza, ma l’expertise. Nel 2001 ero l’unica donna dirigente in Ferrari e mi occupavo dell’extra core business, ovvero sviluppo merchandising, licensing e store. Sono stati sette anni divertenti, ma anche complicati. Quando in una società ingegneristica ti occupi di extra core business quasi nessuno sa ciò che fai».
Parlare con Katia Bassi ti riempie di energia. Mentre ascolto le sue parole ho la sensazione di aver appoggiato la mano su un pad di ricarica wireless. Non vorrei scadere nelle solite domande, parlare del suo ruolo di donna che lavora in ambienti maschili, delle difficoltà che avrà sicuramente affrontato. Ma io voglio, io devo sapere.
«Non mi sono mai chiesta “ho fatto la scelta giusta?”, perché sono una fatalista: se ho fatto questa scelta vuol dire che poi qualcosa deve tornare». Katia Bassi
«Il percorso in Ferrari è stato meno in salita di quanto avessi immaginato. Per me l’importante è che le persone con cui lavoro capiscano quello che voglio fare. Non ho mai voluto imitare un uomo, sarebbe stato un fallimento. È difficile adattare la propria personalità a un cameratismo che non si potrà mai ottenere. Se si recita una parte, prima o poi si verrà scoperti. Ho deciso di essere semplicemente me stessa e di far capire all’azienda quali fossero le mie intenzioni. Quando, dopo molti mesi, sono arrivati i risultati, che hanno inciso pesantemente e in positivo sull’utile netto Ferrari, la situazione è migliorata molto. La pazienza è la chiave di tutto: nel marketing i risultati non arrivano in sei, otto mesi, quindi da un lato devo avere la pazienza di aspettare questo trust mentre l’azienda non può aspettarsi cambiamenti il giorno dopo».
Dopo Ferrari, Katia Bassi è entrata nel mondo dello sport, prima all’Inter, dove si è scontrata con innegabili difficoltà, e poi in NBA. «Il mondo delle società sportive di calcio è un mondo complesso, che nel 2007 era costituto prevalentemente da famiglie di imprenditori. La famiglia tendenzialmente ragiona per dinamiche meno strategiche e più di pancia, e queste dinamiche non mi hanno permesso di lavorare al meglio. Avrei voluto fare la differenza, ma non è stato possibile».
Katia Bassi, nel suo percorso lavorativo, sembra inarrestabile. Rifiuta un posto di dirigente presso uno dei più grandi brand di moda perché non c’era un progetto al suo interno che le permettesse di crescere. Così approda in NBA grazie a un cacciatore di teste inglese che le ha offerto la possibilità di aprire la filiale NBA italiana, mantenendo comunque un presidio a Londra e negli Stati Uniti.
«Gli amici mi diedero della pazza: avrei lasciato l’Inter per andare a occuparmi di uno sport considerato minore in Italia e di cui non sapevo nulla. Erano gli anni in cui Sky iniziava a trasmettere qualche partita di basket, ma in orari assurdi. Non era affatto uno sport mainstream, ma nonostante le difficoltà ho visto chiaramente il progetto che avrei potuto realizzare. Il processo di selezione è stato duro: ho sostenuto 17 colloqui, parlando con ogni divisione dell’azienda compreso il commissioner NBA dell’epoca, David Stern. Mi è piaciuta la visione dell’azienda, nonostante ancora non avessi capito cosa sarei andata a fare. Era il 2009 e per l’NBA il digital era considerato “priorità 1” mentre in Italia i social erano ancora in fase embrionale. Avrei dovuto proporre alle aziende italiane che volevano entrare nel network NBA una pianificazione digital in un momento storico in cui erano ancora tutti fermi alla pagina pubblicitaria sul Corriere della Sera. Un’attività sfidante e di crescita intensa. In quei quattro anni ho portato in Italia i Boston Celtics e i New York Knicks e ho organizzato a Londra la prima partita NBA della regular season. Finalmente il mio lavoro aveva qual taglio internazionale che non aveva avuto all’Inter».
Mi vesto come ho voglia di vestirmi, vengo in ufficio con un accessorio sgargiante e non mi metto in tailleur, non è nella mia indole. Katia Bassi
Mentre è ancora alle prese con l’NBA, Katia riceve la proposta di diventare Managing Director in Aston Martin. Un traguardo che ha un sapore tutto speciale. «All’epoca Aston Martin era di proprietà al 100% di un fondo del Kuwait con referenti di religione musulmana a cui spettava la decisione finale sulle assunzioni. Durante il colloquio con il referente della proprietà non ho ricevuto alcun particolare feedback di apprezzamento, ma appena salita sull’aereo per rientrare in Italia mi è stato comunicato che avevano scelto me. Sarei stata l’unica donna, per di più straniera, nella dirigenza di quell’azienda: la proprietà si era spogliata di qualunque preconcetto legato al ruolo della donna e aveva preso la sua decisione».
La sala riunioni in cui stiamo conversando mi sembra improvvisamente troppo piccola per contenere tutte le anime di questa donna. E il mio registratore sembra troppo piccolo per contenere tutte le domande che si affollano e che vorrebbero uscire impetuose. Non trovo plausibile che una donna così non abbia mai avuto incertezze, non posso credere che sia sempre andato tutto (più o meno) bene. Come si può arrivare a questi livelli senza macerare nei dubbi, nelle domande: avrò fatto la scelta giusta, starò sbagliando qualcosa?
«Non mi sono mai chiesta “ho fatto la scelta giusta?”, perché sono una fatalista: se ho fatto questa scelta vuol dire che poi qualcosa deve tornare. Mi è invece capitato di trovarmi, in due occasioni, di fronte all’invidia da parte di universi femminili a me vicini. Una condizione che ha creato problemi soprattutto a livello personale. Professionalmente parlando si affronta tutto, ma quando l’ambito diventa personale sei costretta a domandarti se è il caso di rimanere e insistere o lasciare l’azienda. Quello che mi ha fatto e che mi fa più male è la mancanza di supporto dalle altre donne, quel mettere in dubbio il motivo per il quale una donna raggiunge posizioni di rilievo. Invece di pensare “bene, è stata brava, tra poco toccherà anche a me”, c’è stato un universo femminile che poi si è trascinato dietro anche il comparto maschile nell’insinuare il dubbio. Questa situazione mi ha molto ferita e mi ha messo talmente in crisi che sono arrivata a pensare che ci fosse qualcosa di sbagliato in me. E mi sono messa in discussione».
Cerco di insinuarmi con delicatezza nelle pieghe delle sue parole e dei suoi pensieri per capire come abbia potuto avere, se l’ha avuta, una vita privata in tutto questo suo girovagare e come riesca a conciliare gli impegni. «Conciliare le due realtà è stato più facile di quanto si possa pensare. Primo perché purtroppo non ho figli, quindi molte delle criticità che si trovano ad affrontare le donne, nel mio caso non sono presenti. E inoltre mio marito è una persona molto aperta e disponibile: ha la fortuna di avere un suo business che gli permette di spostarsi, quindi mi ha seguita nei miei trasferimenti. Siamo rimasti a Londra per 5 anni, in un momento in cui Londra era considerata la New York europea: tutto passava di lì, dagli spettacoli più straordinari alle mostre più esclusive. Ma Londra è anche la città in cui le amicizie sono superficiali e gli incontri con i colleghi al di fuori dell’orario di lavoro sono rari. Ho sentito la mancanza di alcuni punti di riferimento, anche banali, dal supermercato di fiducia al parrucchiere che capisce le tue esigenze».
Dopo l’esperienza londinese, Katia Bassi oggi è rientrata in Italia, approdando in Lamborghini, anche qui unica donna a far parte del board dell’azienda, proprio mentre il progetto del super luxury SUV Urus stava prendendo forma.
Progetto: una parola che ricorre costantemente in questa lunga chiacchierata con Katia. Un obiettivo che ha sempre pilotato le sue scelte, mai comode.
«In Ferrari il progetto era nuovo e a tutto tondo. Montezemolo aveva deciso che l’extra core business dovesse diventare core. Aveva chiaro che il futuro sarebbe stato nell’espansione del mondo licenze per dare visibilità a Ferrari e che era necessaria un’esperienza retail. All’Inter, invece, mi aveva stimolata il progetto di internazionalizzazione proposto dal figlio di Moratti, con espansione in Cina, che vedeva un approccio più da squadra inglese che da club italiano, ma che poi non si è realizzato.
In NBA sono entrata prepotentemente nel mondo digital e social quando in Italia se ne parlava a malapena e in Aston Martin sono arrivata quando il brand stava iniziando una nuova vita e avrebbe voluto raccontarsi in modo diverso rispetto al cliché di James Bond. Infine, in Lamborghini, grazie al progetto Urus, ho capito che la società stava cambiando pelle nel profondo. L’avevo studiata mentre ero in Aston Martin ed era chiaro che il brand automobilistico più cool al mondo stava facendo un ulteriore passo avanti».
«Se un uomo non deve dimostrare nulla perché dovrei farlo io?». Katia Bassi
Katia ammette di essere un po’ incosciente. Un’incoscienza che si augura che sempre più donne possano tirar fuori. Rimango esterrefatta, ma nemmeno poi tanto, quando mi racconta l’episodio di una brillante 23enne, pronta a iniziare una carriera in McKinsey, che decise di rinunciare al lavoro perché per il fidanzato non sarebbe stato opportuno avere un lavoro così impegnativo, considerato che entro quattro o cinque anni probabilmente si sarebbero sposati e avrebbero avuto dei figli. «Se succede che fra quattro o cinque anni avrete dei figli ci penserete in quel momento. Nel frattempo fate tutto quello che c’è da fare. Se poi la situazione sarà troppo dolorosa da gestire, allora modificherete i vostri piani, ma fino ad allora siate un po’ incoscienti e non fate programmi a lunga scadenza».
La guardo, la scruto senza farmi cogliere in fallo. È una donna energica, si vede e si intuisce. Ma la sua è un’energia pacata, calma. Un’energia che si sprigiona senza battere i pugni sul tavolo, un’autorevolezza che, come mi spiegherà, non ha bisogno di un tailleur per rendersi evidente. Le chiedo se si è mai sentita in dovere di dimostrare qualcosa in più perché donna in un mondo di uomini. La riposta è stata tanto ovvia quanto disarmante.
«Non mi sono mai sentita in dovere di dimostrare nulla, ma non perché io abbia un’autostima particolarmente alta. Mi sono semplicemente messa a lavorare come ho sempre fatto. Se un uomo non deve dimostrare nulla perché dovrei farlo io? Mi sono messa in condizione di parità, lavorando al meglio delle mie capacità senza iperperformare. Il mio riferimento è sempre stata l’azienda e il progetto che mi veniva affidato. L’unica domanda che mi faccio sempre è “sto facendo del mio meglio?”, ma come individuo, non come donna, altrimenti perdo già in partenza. Lavorando sempre in contesti molto maschili mi sono detta che se mi hanno scelta, hanno già comprato un pacchetto. Mi vesto come ho voglia di vestirmi, vengo in ufficio con un accessorio sgargiante e non mi metto in tailleur, non è nella mia indole, mi sentirei ridicola. Vedo invece molte donne che si autocastrano, che non vanno ai colloqui per paura di fallire, perché la concorrenza maschile è spietata. Invece dovrebbero andare e mettersi in gioco, sempre. Il peggio che possa capitare è che scelgano un altro, ma nel frattempo avranno fatto esperienza e intessuto nuovi rapporti. Prima del mio colloquio all’Inter il cacciatore di teste mi disse “la avviso, lei sarà l’unica donna al colloquio”. In seguito mi telefonò e mi disse “le comunico che, inaspettatamente, hanno scelto lei”».
Quell’inaspettatamente credo faccia quasi più male a me ora, seduta in questa sala riunioni, che a Katia Bassi durante la telefonata. Ma Katia Bassi dopo quell’inaspettatamente non ha smesso di correre rischi e di essere incosciente, come piace a lei. E anche a me. Al colloquio per l’NBA le chiesero cosa sa di basket?. “Nulla”. Ha mai visto una partita?. “No. Se volete assumere un allenatore queste sono domande lecite, ma se volete una persona che vi crei una struttura sul territorio italiano che funzioni non è necessario che io sappia cos’è un pick and roll“.
Questa è la risposta che avrei sempre voluto dare, ai colloqui, senza mai riuscirci. Katia sì, l’ha fatto. E ha ottenuto il posto.
La sua pacata autorevolezza le ha permesso di realizzare un importante progetto in Lamborghini, il FAB (Lamborghini Female Advisory Board), un network che connette tra loro imprenditrici, docenti universitarie, grandi economiste, startupper illuminate e collezioniste d’arte. «FAB nasce da una doppia esigenza, personale e aziendale: personale perché quando si raggiungono posizioni in cui si può far sentire la propria voce è importante farla sentire davvero, ma non come protesta: come celebrazione. FAB vuole far capire alle donne che il mondo dell’automotive, pur essendo un mondo chiuso, può accogliere le donne che sanno fare la differenza, se le donne faranno un sforzo per entravi. Per quanto riguarda l’azienda, invece, FAB è un’opportunità incredibile. Lavorare nell’iper luxury mi ha portato a studiare tutto il mondo del lusso, non solo quello automobilistico, per fare analisi di marketing predittivo. È chiaro che l’universo delle donne alto spendenti sta crescendo: non acquistano più solo gioielli, ma investono in real estate, in orologi che mantengono un valore nel tempo, investono in opere d’arte e vetture di lusso che si rivalutano nel tempo. FAB nasce, quindi, come osservatorio delle donne alto spendenti che ci raccontano come vogliono vedere una supersportiva domani. L’universo femminile è un universo che vogliamo acquisire sempre di più. Lamborghini parla ungender, quindi non si rivolge a un uomo o a una donna, ma si rivolge a un individuo che ha determinate caratteristiche. Se ti senti parte di questo concetto di lusso informale, Lamborghini fa per te, chiunque tu sia».
Avevo raccolto qualche informazione su questo progetto FAB, ma ero convinta fosse un’iniziativa isolata di Katia Bassi, donna tra gli uomini impegnata a portare avanti il baluardo femminile all’interno di una sorta di riserva indiana. Mi sbagliavo, oh se mi sbagliavo. «FAB è un progetto al 100% Lamborghini e approvato all’unanimità dal board. Quando abbiamo proposto l’istituzione dell’Innovation and transformation Award per le donne sotto i 30 anni alcuni dei colleghi uomini del board si sono proposti di far parte della giuria insieme a una professoressa della UCLA o al capo dipartimento di scienze del MIT, una donna, o una gallerista d’arte della famiglia Tornabuoni. Lamborghini e la sua dirigenza ha sposato il progetto nella sua totalità».
Il tempo a disposizione sta per finire. Io resterei seduta a questo tavolo per ore, ma so che dietro l’angolo la aspettano call, meeting e briefing, anche se non lo dà a vedere. Abbiamo parlato della sua vita scandita dai progetti che ha portato a termine. Non mi resta che chiederle qualcosa del progetto attuale, di Lamborghini e del suo futuro in questa azienda. «Lamborghini oggi è considerato uno dei brand più cool al mondo, ma è un brand giovane, a differenza di Ferrari. La casa del Cavallino ha avuto un percorso di crescita costante durato vent’anni, mentre Lamborghini è esplosa in cinque anni. Ora molte delle energie sono concentrare nel comunicare all’esterno una cultura aziendale che ha davvero molto da dire.
A partire dagli investimenti sullo studio della fibra di carbonio che generano brevetti che poi vengono messi a disposizione degli ospedali. Oppure la gestione dei colori che rende Lamborghini, di fatto, un’azienda di opere d’arte: gli oltre 300 colori disponibili sono costituiti al 90% di acqua, ma su richiesta viene realizzato per il cliente un colore personalizzato, che sarà solo ed esclusivamente suo. Per non parlare di Skyler Gray l’artista che per la prima volta ha dipinto su una vettura, una Aventador S, come fosse una tela. L’auto da lui realizzata è stata monitorata dai nostri ingegneri per tutto il tempo della lavorazione per accertarsi che la carrozzeria avesse lo spessore corretto che ne consentisse l’omologazione. Al termine del lavoro, l’auto è stata acquistata da un collezionista d’arte. È arrivato il momento per Lamborghini di comunicare la propria reason why: dobbiamo lavorare nella direzione di una narrazione che racconti le auto Lamborghini non solo come oggetti di lusso, ma come opere d’arte di valore».
Non ricordo più come siamo poi finite a parlare di Teresa May, di Brexit e della sindrome da crocerossina delle donne. Ora c’è un meeting, un briefing, una call che l’aspettano. Lei non l’ha detto, ma io lo so.
Articolo: Sonia Milan Shooting: Martina Padovan