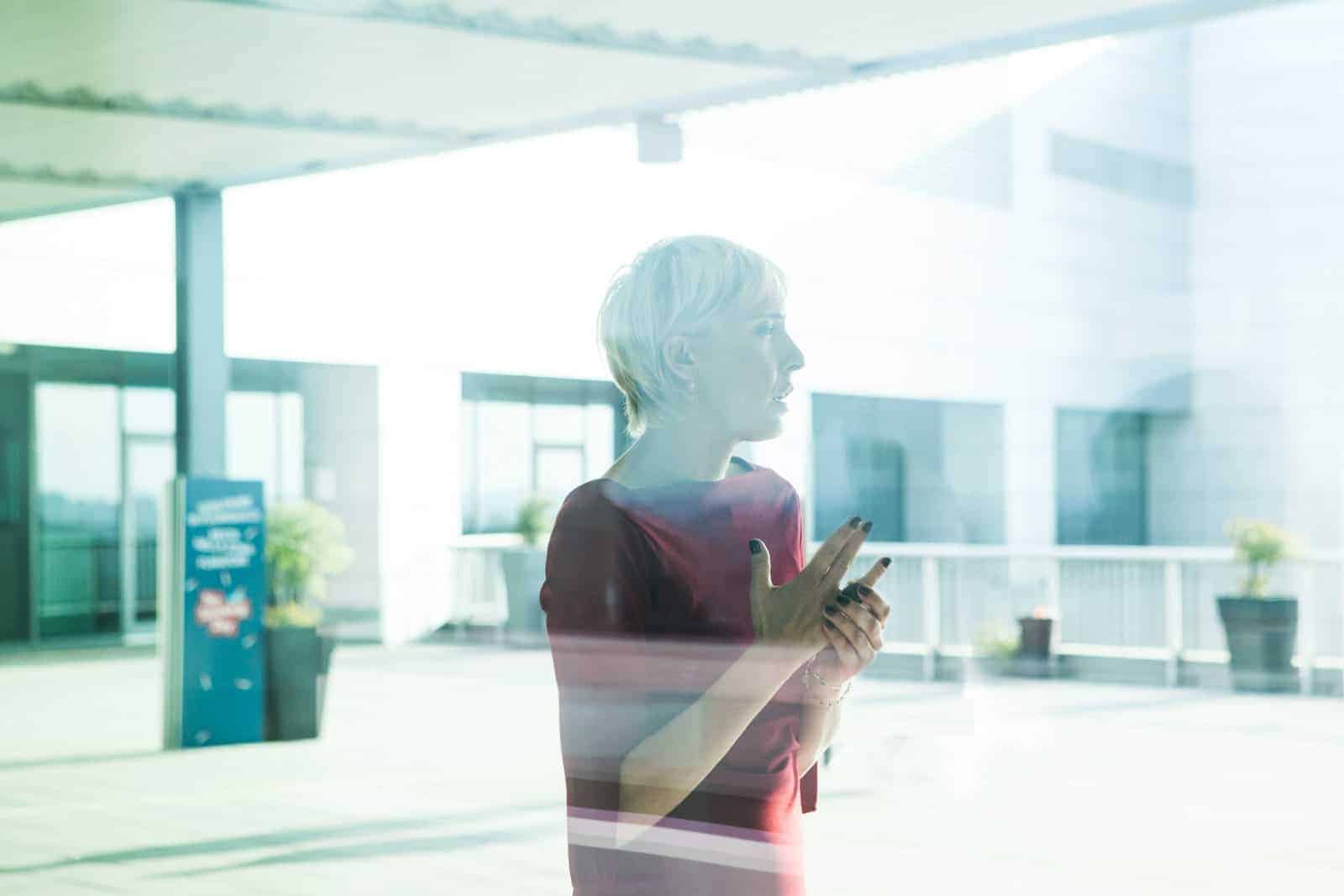Lia Capizzi è la giornalista di Sky Sport più riservata. Non le piacciono molto le interviste, preferisce essere lei a fare le domande. Ma per noi ha fatto un’eccezione.
Amelia Lia Capizzi voleva fare l’ingegnere, ma è diventata giornalista. Una giornalista televisiva che, inaspettatamente, non ha fatto della sua immagine il proprio lasciapassare, ma ha puntato tutto su preparazione, serietà e professionalità. Abbiamo incontrato Lia Capizzi a Milano, negli studi di Sky Sport, il network televisivo per cui lavora ormai da molti anni e abbiamo scoperto una donna che, dietro l’indiscussa bellezza algida e una voce profonda e incredibilmente bella, cela un’energia e una consapevolezza che raramente abbiamo ritrovato in altre persone. Complici un toast e un caffè, abbiamo incontrato una donna che solitamente non si lascia scoprire, ma che coltiva in sé una grande passione per le storie di sport che vale la pena raccontare.
Lia, nel nostro scouting alla ricerca di notizie sulla tua carriera utili ad avere qualche spunto sul quale basare la nostra intervista, in realtà abbiamo trovato pochissimo, come se ci fosse da parte tua una certa riservatezza a rilasciare dichiarazioni e, quindi, a parlare di te.
«Sì, ho questo difetto, sono dannatamente riservata, cosa che fa a pugni con il mio ruolo di personaggio pubblico. Solitamente tendo a rifiutare le interviste: mi piace fare domande, raccontare le persone, ma non parlare di me stessa.
Nonostante io sia un volto televisivo, sono e appaio come una persona estremamente riservata, quasi fredda, cosa quest’ultima che non mi appartiene. La ritengo più una sorta di protezione».
Le (poche) cronache su di te fanno risalire i tuoi esordi in una piccola radio padovana.
«Non ho mai pensato di arrivare a fare la giornalista: provengo da una famiglia numerosa, con tre fratelli, e una passione sportiva derivata da mio padre a cui facevamo compagnia sul divano di fronte alla televisione. Da bambina ho visto interminabili partite di tennis così come tappe intere di Giri d’Italia e Tour De France. Ma oltre a vederne in quantità, di sport ne ho praticato parecchio con il nuoto in primis, ma anche basket e atletica leggera.
Mai, però, avrei immaginato di fare dello sport il mio lavoro. Al liceo classico un amico mi segnalò a una radio locale che cercava personale: da quel momento ho iniziato la mia carriera come speaker radiofonica. Il passaggio successivo a un network radiofonico più importante mi diede la possibilità di entrare nella redazione giornalistica fino al giorno in cui andai a sostenere un provino a Radio 105. E così, da un giorno all’altro, feci armi e bagagli e mi trasferii da Padova a Milano. Era l’epoca delle inchieste di Mani Pulite e facevo gavetta tra cronache giudiziarie, interviste e radiogiornali del mattino. Dopo cinque anni tra Radio 105 e Radio Montecarlo, che mi hanno permesso di sostenere l’esame da giornalista, decisi il salto nel vuoto di un contratto a tempo determinato accettando la proposta di far parte nella redazione sportiva di Mediaset: è stata l’esperienza che mi ha catapultato in una realtà completamente nuova, permettendomi di capire i meccanismi della televisione.
«Solitamente tendo a rifiutare le interviste: mi piace fare domande, raccontare le persone, ma non parlare di me stessa». Lia Capizzi
Allo scadere del contratto venni contattata da Radio Rai 1 per seguire da studio i mondiali di calcio di Corea e Giappone del 2002 affiancando Alfredo Provenzali, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Finito il Mondiale ho condotto “Zona Cesarini”, prima donna in assoluto a farlo: una splendida occasione per parlare di sport in modo colloquiale e mai urlato. Durante quell’esperienza, vedi i casi della vita, arrivò la chiamata di Giovanni Bruno, allora direttore di Sky: non mi aveva mai vista, ma solo ascoltata alla radio. Il mio stile di conduzione lo aveva incuriosito al punto tale che mi propose di entrare a far parte della redazione di Sky Sport. Correva l’anno 2003. Ed eccomi qui.
Appena arrivata a Sky mi venne affidato il compito di seguire il Mondiale di rugby del 2003 in Australia, rimasto negli annali per la finale vinta dall’Inghilterra grazie ad un drop di Jonny Wilkinson negli ultimi secondi della finale. È stata una delle esperienze professionali più intense che abbia mai avuto. Ho scoperto una realtà fatta di valori che ancora oggi fatica ad avere visibilità in Italia, fatto salvo il caso della Nazionale.
Successivamente ho lasciato il rugby per poi riprenderlo seguendo il mondiale in Francia nel 2007. In quell’occasione scrissi un libro a 6 mani con Mauro e Mirko Bergamasco, fratelli provenienti da una famiglia di rugbisti e icone del movimento italiano: un libro nel quale spiegavo il gioco non solo attraverso le regole ma anche, e soprattutto, attraverso le storie che solo uno sport come il rugby è in grado di regalare».
Oltre al rugby, tra gli altri sport seguiti nel tuo lavoro hai una particolare predilezione per il nuoto. Trovi che, nonostante le palesi differenze, si possano trovare degli elementi comuni tra le due discipline?
«Si tratta di sport diametralmente opposti. Nel rugby non ci può essere l’individualismo, hai sempre bisogno del supporto e della spinta del tuo compagno e sei pronto a sacrificarti mettendo la faccia dove in condizioni normali non allungheresti nemmeno un piede. Trovo il rugby uno sport molto formativo, in particolare per i bambini, capace di insegnare l’importanza dello spirito di gruppo e il valore del sacrificio. Ecco, forse quest’ultimo rappresenta l’unico anello di congiunzione tra uno sport come il rugby e il nuoto.
Il nuoto è uno sport in cui il collettivo è visibile solo dietro le quinte quando si parla dello staff di un atleta o nel caso della staffetta. Ma il nuotatore è sempre solo con se stesso in ogni giorno d’allenamento, con la sua fatica e la linea della corsia sempre di fronte a sé. E forse è proprio la fatica che fanno a non essere percepita appieno dalla gente. Ed è anche per tutti i sacrifici taciuti o mai raccontati a sufficienza che ritengo Federica Pellegrini una delle nuotatrici più grandi di sempre. Al di là della sua storia personale non ho mai conosciuto una donna dalla tenacia così forte.
È per questo che mi interessa raccontare le loro gesta: perché il nuoto è uno degli sport più logoranti in assoluto. Tolto un fenomeno assoluto come Michael Pelphs, a trent’anni un nuotatore può essere già considerato a fine carriera. Una nuotatrice come Federica, che a sedici anni sale alla ribalta internazionale e ancora oggi è capace di vincere, è un caso unico nella storia. E non posso non sottolineare la sua forza nel rinascere dopo le batoste subite».
Sky Sport, oltre a rappresentare una vera e propria rivoluzione nel nostro Paese per stile, qualità e cura dei contenuti, per molti aspetti ha contribuito all’emancipazione delle donne nel mondo del giornalismo sportivo.
«È vero, anche se il giornalismo sportivo è un ambito rimasto per tanti anni di pertinenza prettamente maschile e per certi versi lo è ancora. Non lo ritengo però un vero e proprio difetto. Alla donna, considerando soprattutto il mezzo televisivo, oltre alla professionalità viene comunque richiesto un aspetto piacente, cosa che per gli uomini non rappresenta certo un obbligo.
Però non lo vedo un ostacolo e non è mai stata una barriera che impedisse di lavorare. Sono convinta che nel lungo periodo serietà e professionalità paghino sempre e che il giornalismo sportivo a livello femminile oggi possa dirsi completamente emancipato. Certo il nostro ambiente di lavoro, come tutti gli altri, spesso non è facile e quando il contesto lo rende necessario ho un mio piccolo mondo dove decido chi fare entrare, come fosse una sorta di protezione. Diversa, invece, può essere la percezione da parte di un’esigua parte di pubblico, che ora trova nel web uno sfogatoio che permette ad una minoranza di esprimersi senza nessun freno. Sotto questo punto di vista i social media possono essere tremendi, ma sono arrivata al punto per cui le critiche non mi colpiscono più di tanto. Anche io sono presente sul web perché il giornalismo di oggi lo richiede, eppure non ho nessuna bramosia di apparire. Sono molto attiva su Twitter perché lo ritengo la migliore agenzia di stampa per il lavoro. Certo può capitare di esprimere dei pensieri personali, ma l’80% di quanto scrivo sui social media riguarda solo il mio lavoro».
«Qualche anno fa andai in Libano con il desiderio di raccontare storie di ragazzi: profughi siriani che cercavano solo di tornare ad avere un po’ di sole nella loro vita». Lia Capizzi
Sei stata la prima giornalista a commentare in diretta una partita di calcio di serie A, un Messina – Brescia del campionato 2005. Ci sono altri momenti da cristallizzare nella tua carriera?
«Dopo tanti anni di conduzione del telegiornale di Sky Sport, due anni e mezzo fa ero tornata sul campo a fare quello che più mi piace: raccontare storie di sport. Trovo una soddisfazione enorme nell’intervistare persone come Chantal, moglie del compianto Stefano Borgonovo, nell’accompagnare Alex Zanardi ad Amatrice a parlare agli studenti o nel raccontare il lato dolce, e per questo più nascosto, di Federica Pellegrini. Non sento il bisogno o la necessità di apparire in diretta. Qualche anno fa andai in Libano con il desiderio di raccontare storie di ragazzi: profughi siriani che cercavano solo di tornare ad avere un po’ di sole nella loro vita. Incontrai un ragazzo sedicenne, capitano della nazionale giovanile siriana. Lui non si definiva un profugo, perché era un calciatore. Ecco, ci sono emozioni che possono essere espresse solo raccontandone la storia».
Qualche anno fa andai in Libano con il desiderio di raccontare storie di ragazzi: profughi siriani che cercavano solo di tornare ad avere un po’ di sole nella loro vita. Incontrai un ragazzo sedicenne, capitano della nazionale giovanile siriana. Lui non si definiva un profugo, perché era un calciatore. Ecco, ci sono emozioni che possono essere espresse solo raccontandone la storia».
Per quanto, negli ultimi anni, sia aumentata in modo esponenziale l’offerta di contenuti sportivi sui media televisivi e su web, è impossibile non notare una sproporzione tra l’attenzione riservata al calcio e quella per tutte le altre discipline. Tolti gli exploit occasionali come, ad esempio, i successi olimpici o veri e propri brand come il Settebello della pallanuoto o la nazionale di rugby, il calcio continua a essere padrone incontrastato dei palinsesti.
«Mi considero una donna “olimpica” a tutto tondo anche se non nascondo di adorare il calcio. È indubbio che quest’ultimo abbia una posizione dominante nei palinsesti televisivi e sulla stampa, ma la colpa non può e non deve essere data solo ai media. Potremmo parlare di un problema legato alla mancanza di cultura sportiva nel nostro Paese, ma il rischio è quello di cadere nel luogo comune di dire tutto e niente con un unico termine. Credo sia assolutamente necessario andare oltre, perché per costruire una cultura sportiva è fondamentale la partecipazione di tutti: il Coni, le istituzioni, le scuole, i media e anche gli sponsor.
Tutti riuniti attorno a un tavolo alla ricerca della sintesi corretta tra i vari attori che ruotano attorno al mondo sportivo italiano. È troppo comodo dare la colpa ai media della scarsa attenzione riservata agli sport che non siano il calcio. La cultura sportiva è una delle poche cose che invidio ai francesi, insieme al loro senso di appartenenza e di gioia collettiva per un’impresa di un loro connazionale: un aspetto che spesso e volentieri noi italiani dimentichiamo non celebrando a sufficienza i campioni che abbiamo la fortuna di avere».
«Le altre storie che vorrei raccontare hanno tutte a che fare con quella che definisco “la maledizione del quarto posto”». Lia Capizzi
Possiamo a ragione ritenerti una storyteller dello sport. A questo proposito ci hai accennato ai campioni del nostro Paese che non vengono celebrati a sufficienza. Ci sono altre storie di atleti che sarebbero, a tuo avviso, da raccontare anche solo per rendere onore al loro carattere e alla loro determinazione?
«Il primo nome che mi viene in mente è quello di Andrea Dovizioso. La gente non può capire la dedizione e l’impegno che Andrea mette nel suo lavoro: è sempre stato un professionista impeccabile, tra i pochi capaci di dare indicazioni precise ai suoi tecnici. A mio parere rappresenta il prototipo del grande campione che fa un’enorme fatica a emergere perché, ahimè, non è un personaggio.
Le altre storie che vorrei raccontare hanno tutte a che fare con quella che definisco “la maledizione del quarto posto”: uno dei risultati più atroci e beffardi che si possa ottenere nel mondo dello sport. Proprio a un quarto posto è legata una delle mie esperienze più sofferte dal punto di vista lavorativo: Tania Cagnotto ai piedi del podio nella gara di tuffi alle Olimpiadi di Londra del 2012 per venti centesimi. Venti maledetti centesimi. È stata la frase che continuavo a ripetere durante la mia diretta televisiva. Quello fu un momento di vera e propria sofferenza per me al punto tale, una volta finita la diretta, da volermi isolare per riuscire a metabolizzare quanto era successo poco prima. Perché sapevo quanto impegno, dedizione e sacrificio avesse messo Tania per arrivare a cogliere un’occasione unica nella vita, così come sapevo cosa c’era dietro il maledetto quarto posto di altri campioni.
Ci sono quarti posti che fanno male, terribilmente male, ma da cui ti risollevi. Altri di cui non si ricorderà nessuno. Ecco, se ti dovessi raccontare cosa è lo sport ti parlerei di quanta sofferenza ci può essere dietro a un quarto posto».
Articolo: Mauro Farina Shooting fotografico: Barbara Rigon